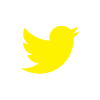Annie è un’orfana di pochi anni che non ha mai perso la speranza di ricongiungersi ai suoi genitori. In attesa di quel momento, Annie condivide la vita con altre ‘camerate’ e sotto la tutela (e il tetto) dell’isterica signorina Hannigan, artista frustrata col vizio dell’imbroglio e della bottiglia. Dinamica ed esplosiva, incontra Benjamin Stacks, facoltoso magnate della telefonia mobile e candidato a sindaco di New York. Salvata dall’uomo per strada, Annie diventa lo strumento per incrementare la sua campagna elettorale. Il gesto eroico di Benjamin accresce la sua popolarità e accende fantasia e ambizione del suo cinico press agent. Su suo consiglio, Benjamin accetta di prendersi cura della ragazzina ma quello che doveva essere un movimento filantropico strategico emergerà presto un sentimento sincero.
Nuovo adattamento di un grande classico americano, Annie – La felicità è contagiosa ha radici profonde che affondano negli anni Venti. Comic strip (“Little Orphan Annie”) di culto nell’America di Franklin Delano Roosevelt, radio show nel 1930, l’orfanella Annie diventa un musical e debutta a Broadway nel 1977, poi al cinema con John Huston nel 1982 e alla televisione con Rob Marshall nel 1999. Creata da Harold Gray nel 1924 per il newyorkese Daily News, la storia della piccola Annie avanzando negli anni e nelle versioni perde la sua incisività politica.
Se il musical modera l’ideologia conservatrice del fumetto e di Warbucks (che significa ‘dollari di guerra’ e rimanda al mestiere del filantropo, produttore di armi), inducendo nel ricco magnate un tiepido ripensamento circa la propria adesione incondizionata al capitalismo, il film di Huston coniuga la dimensione favolistica con la crisi del sogno americano durante la Grande Depressione, piegando l’irriducibilità di Warbucks attraverso l’amore per Annie e l’adesione (sfumata) al New Deal di Roosevelt, fortemente contrastato dall’ultraconservatore Gray.
Diversamente la soap musicale di Will Gluck, prodotta da Will Smith e Jay-Z e ambientata nell’America ‘post-razziale’ di Obama, è un campionario superficiale di atteggiamenti e sentimenti che non va oltre la meccanica applicazione di una formula di genere. L’unico elemento di ‘originalità’ risiede nei protagonisti, l’orfanella è nera come il suo benefattore opportunista, un anonimo Jamie Foxx, che spera di farsi eleggere sindaco a New York. Naufragio estetico e ideologico, Annie è irrisorio sulla questione razziale e suggerisce l’azione individuale e la carità come sole soluzioni.
La dose di realismo, introdotta da John Huston per scongiurare gli scivoloni nello stucchevole buonismo, difetta a Gluck, che sbaglia gli accordi e il ‘cattivo’, sulla cui verve caricaturale poggia da sempre questa commedia musicale. Più cool che bad guy, Jamie Foxx, di cui conosciamo e apprezziamo il talento, non ha o non trova i tempi del ballerino, quelli del villain e quelli del singer, finendo battuto e soverchiato da una ragazzina più leziosa di Shirley Temple, che spinge insopportabilmente sul pedale della ‘carineria’. Ambientata in origine nell’America della Grande Depressione, la favola di Annie precipita nell’era dei cellulari che hanno fatto la fortuna di Benjamin Stacks, che in casa ha più schermi che muri, che si sposta in elicottero e ‘aggiusta’ nome (Oliver Warbucks) e professione (produttore di armi).
Will Gluck fa insomma tabula rasa del passato, rimaneggia la sceneggiatura, scarta alcune canzoni, ne ri-arrangia altre, ne compone di nuove per l’occasione, rendendo quasi irriconoscibile la materia di partenza e una storia troppo bella per essere vera. Eluso qualsiasi contesto storico e sociale, qualsiasi elemento sordido o ambiguo, qualsiasi ombra di crisi, qualsiasi complessità narrativa, il regista punta sulla favola e sul carisma dell’interprete principale, Quvenzhané Wallis, scaltra, accattivante e di contagiosa bravura. Rivelata da Benh Zeitlin in Re della Terra Selvaggia, la Wallis ha avuto la meglio su Willow Smith, la figlia del noto attore, e a fianco di un filantropo, il cui credito sociologico si fonda su un’infanzia difficile rievocata con spavalda rapidità. A chiudere, Gluck non riesce a creare quella coerenza interna al musical che fa delle sequenze di danza e di canto la naturale proiezione di uno stato d’animo o di una situazione. A mancare è l’emozione autentica. D’altra parte le interminabili sequenze ballate e cantate si svolgono tutte nel cuore di Manhattan, lontano dai marciapiedi sporchi di Harlem e al riparo dagli sguardi di prostitute e clochard. Perché solo vicini al cielo e dentro un attico si può cantare plausibilmente: “I think I’m gonna to like it here!”.
Al momento non in programmazione